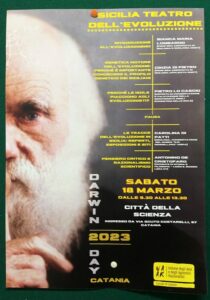di Paola Giordano
Non rinnegare mai a te stesso ciò per cui hai combattuto.
La sconfitta non rende ingiusta una causa.
Alberto Moravia
Sono trascorsi parecchi mesi dal fatidico annuncio che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fece la sera del 9 marzo per esporre le misure restrittive varate allo scopo di contrastare la diffusione del Coronavirus:
Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini ma i numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e sub-intensiva ed anche, ahimè, delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate e vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo a norme più stringenti.
La salute di tutti i cittadini è il nostro obiettivo primario: se messa a repentaglio noi siamo costretti a scegliere e a imporre dei sacrifici per quanto riguarda gli altri interessi, pur meritevoli di tutela. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione ‘io resto a casa’. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona uno e la zona due della Penisola: ci sarà l’Italia, un’Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della Penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o motivi di salute.
Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all’aperto e in locali aperti al pubblico.[1]
Le nostre vite da quel momento, dopo quelle parole, sono profondamente cambiate: niente riunioni familiari, niente uscite o cene con gli amici, niente abbracci. Tutti chiusi in casa, salvo chi per motivi di lavoro o ragioni di salute era costretto a spostarsi nella propria città o in un altro Comune.
Inaspettatamente, siamo stati piuttosto bravi a rispettare le disposizioni del Governo e della Regione. Inaspettatamente, perché come dicevano già i latini facta lex, inventa fraus (“fatta la legge, trovato l’inganno”).
Diciamoci la verità: il rispetto delle regole non è mai stato il nostro cavallo di battaglia. Eppure, in questa particolare occasione, inaspettatamente, non siamo andati a cercare l’inganno: fatta la legge, l’abbiamo rispettata, smarcandoci dai cliché e diventando addirittura un esempio per l’Europa e per il mondo, un modello che alcuni Stati hanno deciso di seguire. Persino il New York Times ha lodato la gestione della pandemia da parte del nostro Paese: nell’articolo pubblicato lo scorso 31 luglio dal titolo “How Italy Turned Around Its Coronavirus Calamity”, il giornalista Jason Horowitz, corrispondente da Roma del quotidiano newyorkese, scriveva:
How Italy has gone from being a global pariah to a model — however imperfect — of viral containment holds fresh lessons for the rest of the world, including the United States, where the virus, never under control, now rages across the country.[2]
Un modello per il resto del mondo, dunque, per quanto imperfetto. Ma pur sempre un modello. Che di fronte a quel provvedimento – per alcuni necessario, per altri discutibile, per altri ancora ingiusto – che imponeva di restare a casa ci ha costretti a ingegnare nuovi modi per stare in contatto con gli altri. Modi che di certo non abbiamo inventato noi – gli altri Paesi li usano da tempo – ma che abbiamo imparato a usare e di cui abbiamo sfruttato le potenzialità.
Per sentirsi più vicini nonostante la lontananza fisica abbiamo infatti sperimentato innovativi (per noi) strumenti di comunicazione che ci sono stati utili anche sul lavoro: ci siamo videochiamati, abbiamo fatto conference call con colleghi, clienti, capi. E ci siamo dati appuntamento sui balconi, cantando all’unisono le grandi canzoni del passato, le hit del presente, l’Inno d’Italia: “Noi fummo da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi. Raccolgaci un’unica bandiera, una speme: di fonderci insieme già l’ora suonò”.
In quei lunghi giorni, dove ansia, paure e preoccupazioni padroneggiavano le nostre menti, abbiamo creduto di essere un’unica bandiera. I gesti di solidarietà che lo confermavano sono stati tanti. L’Ospedale Civico di Palermo accolse all’alba del 14 marzo e curò il bergamasco Ettore Consonni, sessantunenne ricoverato e intubato a Seriate (Bg) una decina di giorni prima. Il primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori, per ricambiare l’assistenza nei confronti di Ettore e di altri cittadini bergamaschi curati a Palermo, spedì tablet e pc per i bambini della scuola “Falcone” allo Zen.
Così agisce un Paese unito: tendendo la mano a chi è più in difficoltà. Così dovrebbe essere sempre. Tra il dire e il fare, però, può esserci di mezzo l’oceano.
Abbiamo creduto che l’ora di fonderci insieme fosse finalmente scoccata, ci siamo piacevolmente illusi che fosse possibile. Quella del coronavirus avrebbe potuto essere l’occasione di diventare realmente un popolo. E invece si è tramutata in un’altra, l’ennesima occasione mancata. Il campanilismo delle Regioni, l’eterna diatriba tra Nord e Sud hanno prevalso sulla speme di appartenere a quell’unica bandiera che tanto ci inorgoglisce quando la nazionale di calcio disputa i mondiali ma di cui ci si dimentica, con una facilità quasi imbarazzante, quando la partita finisce.
All’assist che il giornalista di Libero Lorenzo Mottola gli ha offerto nell’intervista pubblicata il 20 aprile “Ora De Luca (Vincenzo, Presidente della Regione Campania, ndr) minaccia di sospendere i collegamenti con il Nord se deciderete di far ripartire le attività produttive”, l’assessore regionale al welfare della Regione Lombarda, Giulio Gallera, risponde tirando dritto in porta:
In realtà le misure che abbiamo previsto hanno prodotto un grande risultato, noi avevamo di fronte proiezioni agghiaccianti fatte dai nostri analisti, per questo abbiamo messo in campo misure di contenimento per evitare di avere centinaia di migliaia di contagiati in più. Senza le misure adottate grazie alle nostre insistenze sarebbe stato un disastro.[3]
E di fronte alla provocazione di Mottola “In pratica mi dice che il Sud l’avete salvato voi?”, l’assessore conferma: “Certo, assolutamente”.
Di episodi – diversi sì tra loro ma aventi le medesime conseguenze – ce ne sono tanti altri e tutti, insieme, non hanno fatto altro che acuire dissidi esistenti da sempre, insinuare sospetti, dividere.
Dopo varie nottate trascorse a impedire – con tanto di diretta sui social network – che i traghetti attraccassero nel porto della sua città, con un’ordinanza sindacale entrata in vigore l’8 aprile, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha istituito ad esempio una banca dati online per disciplinare gli arrivi dallo Stretto, imponendo a chi facesse ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia a piedi sia a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, di accedere ad un sistema di registrazione online tramite un sito dal fantasioso url www.sipassaacondizione.comune.messina.it, almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza. E facendo egli stesso i controlli con la polizia municipale alla Rada San Francesco per verificare se i passeggeri che sbarcavano dai traghetti fossero registrati o meno e se avessero validi motivi per entrare nella città dello Stretto[4].
A chi attribuire la colpa? A uno, nessuno e centomila. La questione non è trovare un capro espiatorio: siamo tutti responsabili, in fondo. Tanto chi ha sposato le tesi di Gallera quanto chi ha applaudito le gesta di De Luca. Abbiamo quindi perso tutti. Perché nel momento in cui abbiamo iniziato a guardare l’altro con sospetto, con timore, ci siamo lasciati trasportare dall’egoismo, abbiamo lasciato che l’istinto dominasse la ragione.
È lo spirito di sopravvivenza a guidarci: homo homini lupus recita il proverbio pessimistico, derivato dall’Asinaria di Plauto che allude all’egoismo umano, e assunto dal filosofo inglese Thomas Hobbes, nella sua opera De cive, per designare lo stato di natura in cui gli uomini, soggiogati dall’egoismo, si combattono l’un l’altro per sopravvivere[5].
L’uomo infatti è sì un politikòn zôon, per usare le parole di Aristotele, ma lo è fino a un certo punto. Fino a quando cioè qualcosa o qualcuno non minacci la propria persona, i propri beni, siano essi materiali o immateriali. Nel momento in cui qualcosa o qualcuno invada il proprio “giardino” o mini la propria sfera personale, dell’animale politico resta solo l’animale.
Finché il virus è rimasto circoscritto in Sicilia a pochi casi, ad esempio, apparivamo e ci mostravamo come “isola felice”. Quando il numero dei contagiati si è impennato, però, ecco che si è smesso di cantare l’inno sui balconi ed è scattata l’ossessione per la vecchia e sovraccarica Renault 4 con targa francese che circolava a fine marzo da una provincia siciliana all’altra.
Così si è iniziato a pretendere di chiudere i confini, a bollare come untore chi rientrava a casa propria dal Nord, ad accusare i migranti di essere i diffusori del virus. Così come era arrivato – all’improvviso, insieme al Covid – il sentimento di essere un unico popolo, altrettanto improvvisamente se ne è andato.
Il virus avrebbe dovuto renderci persone migliori, doveva essere l’occasione per acquisire un’identità di popolo più matura, potevamo diventare finalmente una sola nazione. Eppure, neanche una pandemia è riuscita nell’impresa.
In foto: R. Magritte, Gli amanti, 1928, olio su tela, 54×73 cm, MoMA, New York
[1] Cfr. http://www.governo.it/it/media/dichiarazioni-alla-stampa-del-presidente-conte/14274. Consultato il 14/11/2020.
[2] Cfr. https://www.nytimes.com/2020/07/31/world/europe/italy-coronavirus-reopening.html. Consultato il 14/11/2020.
[3] Cfr. https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/22214074/giulio_gallera_libero_coronavirus_milano_salvato_sud_italia_risposta_boccia_de_luca.html. Consultato il 17/11/2020.
[4] Cfr. https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2020/04/08/coronavirus-sindaco-messina-controlla-arrivi-sullo-stretto_5caf14dd-74b8-45de-a4a0-b8438a41b5b3.html. Consultato il 17/11/2020.
[5] Cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/homo-homini-lupus/. Consultato il 14/11/2020.