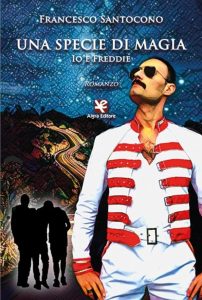Recensione a:
D. Susanetti,
L’altrove della tragedia greca. Scene, parole e immagini
Carocci, Roma 2023
Pagine 187
€20,00
di Stefano Piazzese
In apertura Susanetti pone una domanda che guida lo sviluppo degli argomenti affrontati nelle pagine e nei capitoli successivi: «che cos’è, in fondo, una tragedia greca se non lo spettacolo di un’azione che conduce alla metabolé[1], al “mutamento” radicale della vita e del pensiero?» (p. 10). La tragedia greca è un itinerario in cui è possibile riflettere sugli aspetti più profondi dell’esistenza e del modo di pensare i caratteri fondamentali della vita umana, sicché il presente tempo, caratterizzato dall’inarrestabile incedere di trasformazioni e mutamenti che scuotono il bagaglio di sapere di volta in volta acquisito, esige una riscoperta della sapienza tragica, se non altro per la sopravvivenza stessa di Homo sapiens che, ebbro dei traguardi della tecnica e in balia del proprio delirio di onnipotenza , sembra aver smarrito la misura.
La tragedia greca è un altrove in quanto invito alla complessità, altro luogo (alĭter ŭbi) rispetto al già dato, al già definito; essa è il perturbante per eccellenza che permette alla vita umana di non (s)cadere nel baratro dell’ignoranza. Ma qui ignoranza acquisisce un significato ben preciso e non generico: ignorare l’altrove dell’esperienza, l’altrove del giudizio, l’altrove del dolore, l’altrove della conoscenza, l’altrove della giustizia, l’altrove del corpo, l’altrove della decisione, l’altrove della gioia, l’altrove del trionfo.
Tendenza piuttosto diffusa tra gli uomini, infatti, è quella di cercare del continuo conferme per sentirsi approvato in ciò che si è raggiunto, in quello che si è, nelle proprie idee, definizioni e pensieri. La tragedia, non solo in merito a ciò, è l’altrove della filosofia, il suo altro luogo, nel senso che la prima costituisce uno ‘spazio’ del pensiero speculativo del tutto originale e mai superato della prima. La storia della filosofia testimonia questa affermazione poiché quanto sorto dalla tragedia ha animato il pensiero filosofico dall’antichità sino ai nostri giorni.
Dal perturbante viene lo spaesamento che la tragedia produce, ovvero
qualcosa che non ci confermi in ciò che siamo, un “altrove” che, proprio per la sua distanza ed estraneità, ci spaesi e ci contraddica, dischiudendo la possibilità di altro. Un altro che non sarà, se mai sarà, ripetizione del dato, ma insorgenza ulteriore prodotta da una frizione, immagine che rovescia e rigenera lo sguardo […] una fenomenologia dell’esperienza per fare, a propria volta, esperienza, senza gettarsi, immediatamente e senza rete, nell’incandescenza del reale (p. 10).
E l’altrove della tragedia non può non mostrare l’ineluttabilità del dolore che tocca la vita di ogni essere umano; dalle vicende narrate nelle tragedie emerge il “prisma cangiante e doloroso” la cui manifestazione non è circoscritta, certo, ai soli protagonisti del dramma. Per i mortali è sempre prossimo «un campo di forze o un orizzonte invisibile in cui ciascuno è gettato e brancola, ancorché non se ne avveda e ritenga di procedere con passo sicuro, fino a che qualcosa inopinatamente accade» (p. 15).
Quella di Susanetti è una riflessione che, prendendo le mosse dalla dimensione filologica, mostra la bellezza abissale dell’universo semantico della tragedia. Sin dall’inizio della lettura è possibile notare che il profondo rapporto e la minuziosa attenzione dell’autore per i concetti mai si traduce in sterile esposizione erudita, ma in vivace e teoreticamente stimolante riflessione che restituisce l’inesauribile ricchezza di ciò che sta a fondamento della nostra civiltà.
A proposito delle parole, dei concetti fondanti del tragico, nello smarrimento del senso della misura si incontra colui che è authádes, ovvero chi vive un’autoreferenzialità cronica che repelle quanto è estraneo o lontano dalla propria Stimmung, «authádes è chi si piace e si compiace di sé e da sé, che fa o pensa solo ciò che gli è gradito e gli corrisponde, senza tener conto di nulla che sia diverso ed estraneo alla propria persona» (pp. 16-17). L’assenza della misura si manifesta, in chi è authádes, nel non vedere e ascoltare altro e altri all’infuori di sé, e dunque nel vivere in perenne chiusura verso l’altrove a cui la tragedia costantemente rimanda. Non è questa una forma di tracotanza che la vita stessa (enti, eventi e processi) s’incaricherà di punire?
Chi è authádes è del tutto incapace di éikein, di “cedere” a un’altra istanza, di “fare un passo indietro rispetto alla propria posizione o al proprio convincimento. […] Da qui sorge quella húbris, quella “dismisura” che così spesso suona sinistramente nella tragedia: chi si compiace di sé e non è disposto a cedere finisce sempre per passare il segno perché, non riconoscendo altro, non riconosce neppure il proprio limite (p. 17).
Di fronte alle molteplici forme della dismisura, la cui pericolosità per la vita della pólis è avvertita ed evidenziata con forza da Eschilo, «c’è bisogno di un pensiero profondo che dia salvezza» (Supplici, vv. 407-417) (p. 37), di un discorso che salva. È possibile un discorso capace di risolvere la presa dell’aporia e del dolore? Se inaggirabile appare l’inevitabilità del danno, forse l’unico pensiero che dà salvezza è quello che comprende la sovranità di Anánkē e ad essa si abbandona. Ecco perché colui che conosce è solamente il «sóphos kakón, “sapiente dei mali”. E se proprio quella fosse, per certi versi, la via della sapienza per i mortali, fintanto che essi pensano e vivono cose mortali, tra altri umani, nel cerchio della pólis?» (p. 38). Pertanto, l’unica via della sapienza è segnata dall’esperienza e dalla consapevolezza del dolore. Qui Susanetti precisa che peithó (persuasione) e túche (sorte) sono «le due sole cose che restano dinanzi alla “necessità che non si sceglie e non si vuole, le uniche due risorse a cui affidarsi, non per trovare salvezza, ma per essere uniti e concordi in ciò che si deve fare e deve accadere» (p. 40).
Dalla dinamica della decisione, che attraversa e scandisce la narrazione di tutte le tragedie, sorgono le domande della filosofia che abbracciano vari aspetti dell’esistere, tra i quali un posto particolare spetta al tratto politico di quell’altrove di cui parla Susanetti, «perché c’è, in ogni caso, la città: c’è e ci deve essere pólis. E c’è e ci deve essere la tragedia a farle da specchio nelle forme che la costituiscono, così come nell’evento che, ogni volta, la minaccia, nel fondo scuro in cui, a ogni passo, può cadere» (p. 42). La domanda per eccellenza – ti dráso -, come in Sette contro Tebe, esprime la disperazione della pólis immersa nel terrore della guerra incombente. La città stessa è dimensione politica della tragedia attica e la riflessione del tragico, grazie a essa, si fa argomento geopolitico sicché sono anche le città a essere protagoniste delle vicende: Atene, Argo, Micene, Corinto, Tebe.
In riferimento ad Atene, Susanetti rileva una differenza rispetto alle altre città pocanzi menzionate poiché essa è «la pólis in cui ogni cosa si media e si risolve, in cui ogni vicenda si ricompone. La città che, in modo tanto disinteressato quanto ideale, si erge a difesa della giustizia e dell’equità al di sopra delle parti» (p. 50). Questo vuol dire che la pólis, non costituendo un aspetto marginale della tragedia, è protagonista della storia; la sua vicenda travalica i confini spazio-temporali che la definiscono per divenire il dove e il quando di altre póleis. Ecco perché
Atene è Atene, ma anche Tebe e tutti gli altri luoghi delle storie antiche che prendono corpo e voce nel tempo dello spettacolo. È questo il dono prezioso che Dioniso offre alla pólis. Far riconoscere ed esperire, nella dinamica protetta della finzione teatrale, il “proprio” intimo male. Solo in questo modo, forse, vi possono essere un “dove” e un “quando” in cui le cose si risolvono (p. 54).
Il dono prezioso che Dioniso offre alla città è uno dei grandi moniti della sapienza tragica. Accanto al conoscere che viene dal patire vi è il consiglio supremo rivolto a colui la cui esistenza s’imbatte nello scoglio invisibile di Necessità: «“impara a cedere” […] Non è questa, d’altro canto, la legge suprema che governa ogni cosa nella danza degli opposti che, a vicenda, si piegano gli uni agli altri?» (p. 69). Il cedimento non ha qui un connotato negativo che denota debolezza o rassegnazione a uno stato di ‘inferiorità’, bensì vuol dire “aprirsi all’impensato” (p. 70), all’inatteso, e cioè attingere a un pensiero che accoglie la contraddizione del vivente. Da questo fondo oscuro apparentemente incomprensibile, in cui ogni discorso ben formulato deve fare i conti con quanto lo trascende rispetto a ciò che afferma, come accade in Aiace, sorge la domanda: «che dire della vita di uomo? Può essa tornare dopo che ha ceduto all’opposto della morte?» (p. 70). Lo scontro in atto nella tragedia è tra l’evento e la forma (Carlo Diano), e in questo agón la forma dell’eroe s’infrange urtando con quanto gli è opposto, ma va precisato che «in questa fine volontariamente assunta e cercata, la forma trova anche la propria paradossale salvezza, poiché, gettandosi nell’abbraccio della morte, essa si sottrae per sempre a ogni mutamento» (p. 70). Corrispondere a questa dinamica vuol dire avere misura, la misura che conduce il mortale alla saggezza e che regge la vita della città.
Il pólemos della tragedia si dà, ancora, nella stásis glósses, conflitto di parole o sedizione della lingua, «perché anche le parole, una volta pronunciate, agiscono e producono una catena di conseguenze che non possono essere annullate. La tragedia è fatta di parole con cui i personaggi esprimono le proprie emozioni» (p. 75). A essere interrogato è il linguaggio stesso, posto costantemente di fronte ai propri limiti, e in particolare il discorso politico che, come nel caso di Antigone, porta alla luce lo scontro tra Ade e Giustizia che reclamano il seppellimento del fratello a dispetto delle leggi che reggono la pólis, e, allo stesso tempo, la colpa che piomba su chi non rispetta queste leggi. Ecco che «il contrasto è assoluto e senza possibilità di contatto» (p. 80). Anche in merito a ciò è opportuno porre attenzione alle parole
come sébein, “venerare”, il verbo che, in primo luogo, concerne la reverenza e il timore per ciò che trascende la comune misura dell’umano: gli dei e quanto a essi deve essere riferito. Sébein per Antigone si dice esclusivamente in rapporto ad Ade, al signore degli inferi, e a quell’aldilà, ove ormai sono tutti i suoi cari. […] Per Creonte, all’opposto, il sébein pertiene e ha senso esclusivamente rispetto alla comunità politica dei vivi e all’ordine che la regge: “venerazione” per il potere costituito, “venerazione” per le leggi e le decisioni della città, “rispetto” indefettibile per il comando e per colui che legittimamente lo detiene (pp. 80-81).
È possibile che il sébein sia rivolto in modo acritico all’autorità il cui esercizio del potere permette che la città non sprofondi nell’anarchia? Eschilo pose un pensiero intriso di sapienza tragica, di misura, che anche Sofocle ed Euripide fecero proprio: «Né l’anarchia nella vita | ma neppure la sudditanza a un padrone | è da apprezzare: | tutto quanto sta nel mezzo il dio favorisce | e in vari modi sorveglia» (Aeschl. Eum., vv.517-537, trad. di M. Centanni).
L’agón logón che si sviluppa nell’azione drammatica, afferma l’autore, è l’aspetto della tragedia che più definisce il proprio rapporto con la filosofia, in quanto esso non è solo un momento centrale, determinante, dell’azione tragica, altresì si struttura e si rivela una grande occasione di pensiero (p. 82) che indaga le problematicità dell’esistenza che emergono dall’evento.
Un degli aspetti più suggestivi del percorso delineato dall’autore è l’attenzione al corpo come elemento tutt’altro che marginale dell’agone tragico; ragion per cui, leggiamo al capitolo otto, tragedia «non è solo parole, ma anche spettacolo di corpi in cui la sventura si palesa come traccia indelebile e cruda, come distruzione che annienta la figura e la fisicità del vivente» (p. 89). Cos’è quello di Ecuba (Troiane) se non un corpo ridotto a nuda vita? La realtà del dolore che pertiene alla vita umana è vista, considerata ed esperita a partire da «un sóma che traduce, nella sua postura e nel dolore fisico che lo attraversa, la fine stessa della pólis» (p. 90).
In Troiane sono le stesse metafore a indicare la relazione tra il corpo di Ecuba e la comunità politica. Quanto siano vicine le riflessioni di Susanetti che sorgono dal terreno della tragedia ai nostri giorni è testimoniato da quella che l’autore chiama «poesia dei corpi devastati dalla sventura. Poesia che trasfigura la pena e insieme ricorda quella soglia dell’“invisibile” cui il mortale è destinato. Sacrificio supremo della poesia bagnata nel sangue» (p. 99). In questo momento buio della storia, l’altrove della tragedia si mostra quale momento intenso di riflessione che permette a chi lo esplora e si lascia interrogare da esso di comprendere il proprio tempo nel pensiero.
[1] Per la traslitterazione dei termini greci è stata rispettata qui la scelta dell’autore esplicitata a p. 185.