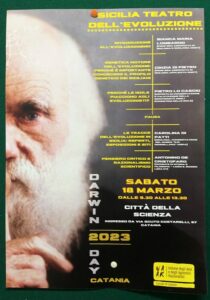Il titolo che ho deciso di dare a questo scritto, a consuntivo di quanto ho visto, pensato e riflettuto su questo periodo così buio, è debitore di un’opera tra le più importanti della filosofia e della critica della cultura dell’intero Novecento. Sarebbe meglio dire che ne è proprio un calco. Il libro a cui faccio riferimento è l’opera del 1936 di Walter Benjamin Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in italiano L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Riassumendo all’osso le tesi del filosofo tedesco, si può affermare che la riproduzione delle opere d’arte dovuta agli strumenti tecnologici, di più o meno recente invenzione come la macchina fotografica o la cinepresa, avrebbe privato le opere stesse della loro aura. In qualche modo, dice Benjamin, le opere d’arte, uniche e irripetibili, rischiano di perdere il loro carattere di assoluta eccezionalità a causa delle innumerevoli copie che di esse vengono riprodotte. Per constatare quanto la sua intuizione sia corretta e rimasta intatta nel corso dei decenni, si possono richiamare alla mente i tantissimi episodi di dispersione di un’opera non soltanto in immagini di grande formato e ad alta fedeltà ma anche in medium di diversa natura. Il volto della Gioconda si può vedere infatti al Louvre, sul proprio comodino, in un’insegna pubblicitaria, in un costume di balneazione o su uno smartphone.
Si direbbe una vera e propria disdetta per l’originalità dell’arte, tanto da credere che le visite a musei e gallerie possano ritenersi non più necessarie. Eppure, malgrado la riproduzione abbia minato l’aura di intangibilità e purezza dell’opera d’arte, l’emozione che si prova a vederne una dal vivo resta insostituibile, proprio come lo è del resto l’opera stessa, il modo corretto per osservare la quale rimane sì con gli occhi ma con i piedi, trovarsi cioè nella stessa dimensione spaziotemporale della sala o della chiesa in cui essa è custodita.
Tra le tante iniziative di queste ultime settimane c’è stata l’apertura dei battenti virtuali da parte di alcuni dei principali musei del mondo, che tramite piattaforme digitali hanno istituito percorsi guidati da iniziare, godere (sub judice) e concludere direttamente dal divano di casa propria. Le nostre case, anche in ciò, hanno esaudito più che mai il geniale racconto di Borges Aleph, un punto dell’universo che contenga potenzialmente tutti i luoghi.
Ma quale potrebbe essere la coerenza di Benjamin e della sua riflessione con la nostra epoca, messa in subbuglio e sotto scacco da un esserino minuscolo a confine tra la vita e la non-vita, che non sa nemmeno cosa siano i corpi in cui vive e che senza volere infetta e uccide?
Cambiando il soggetto e le circostanze dell’indagine benjaminiana, assumendo come temi d’analisi non l’opera d’arte ma le relazioni sociali e considerando piuttosto che la riproducibilità tecnica la diffusione di tali relazioni nelle piattaforme digitali e multimediali, cosa se ne ricava? La socialità ai tempi del Coronavirus mi è parsa e continua a sembrarmi esattamente come il nemico silenzioso che ci ostiniamo a combattere a scapito di questa stessa socialità, ovvero virale.
Un fatto o una notizia divengono virali quando raggiungono una diffusione tale da diventare una conoscenza quasi assoluta da parte degli utenti. Ma non è in questo senso che voglio intendere il termine. Semmai la socialità è diventata virale poiché essa si esplica e si riversa nei canali con cui viralmente siamo connessi gli uni con gli altri: Social-Network, notiziari, giornali, videochiamate, telefonate, messaggi. Mai come ora, ed è la tesi che voglio sostenere, la socialità mi è sembrata così evidente e pervasiva. In una fase in cui non è possibile incontrarsi come si incontra con occhi e piedi un’opera d’arte in un museo, allo stesso modo gli umani di quasi tutto il mondo intrattengono relazioni per mezzo degli unici strumenti che glielo consentano: la rete e i suoi surrogati.
Per mestiere e per vocazione trascorro gran parte delle mie giornate nella mia stanza a leggere, scrivere e tentare di comprendere. Non ho quindi vissuto con particolare sofferenza l’invasione del virus nelle nostre vite. A questo proposito trovo illuminante come non mai la celebre frase pascaliana: «Tutta l’infelicità dell’uomo deriva dalla sua incapacità di starsene nella sua stanza da solo». Ritengo che gran parte dei comprensibili fallimenti sottintesi al motto io resto a casa sia contenuta e sintetizzata in questa massima così smagliante. Nel piccolo mondo ipercollegato della mia stanza, in questi giorni ho bisogno di caricare il telefono per più volte anche in una sola giornata, a causa dei continui messaggi e stimoli di interazione che ricevo e che a volte sono costretto a ignorare. Ciò mi fa pensare che il mio Aleph è incandescente come lo è la necessità umana di queste ultime settimane di esercitare la socialità in carne e ossa.
Non potendosi incontrare fisicamente, ci si è organizzati – spesse volte devo ammettere con esiti esilaranti – nelle maniere più improbabili. Inutile dire che la piattaforma più utilizzata è stata Facebook, che sono certo in questi giorni abbia toccato il picco di contagiati. Anche io, sebbene da utente svagato, ho utilizzato Facebook dedicandovi qualche pensiero fugace o leggendo qua e là per carpire quali fossero gli umori generali o più condivisi. Ho un’opinione molto negativa dei Social e questa quarantena me ne ha dimostrato ancor di più la bassezza. L’immagine più appropriata per descriverli – specie adesso – potrebbe essere un ristorante o una piazza affollata in cui tutti parlano ma senza ascoltarsi davvero, con il solo risultato di un fastidioso e incomprensibile brusio di fondo.
Ne ho lette di tutti i tipi: richiami alle rivolte, invocazioni militari, spettacoli assai patetici di politica da cabaret, poveri di spirito divenuti Paolo di Tarso, stillicidi di sfrenato e infondato opinionismo, complottisti degni di figurare in un romanzo inedito di Umberto Eco, soggetti indignati e sfiniti da questa folla berciante richiamare vanamente alla lucidità. Tutti accusano tutti gli altri di aver originato il virus, anche le lobbies che starebbero dietro a Greta Thunberg; e magari avrebbero ragione, perché il pianeta ne fa festa. Ma la mia preferita è constatare la coincidenza – o forse un piano occulto, non si sa mai – tra la quarantena e la quaresima appena conclusa, in cui avrebbe dovuto regnare per tutti i devoti per finta la celebre risposta di Gesù nel deserto al diavolo tentatore e riportata dall’evangelista Matteo: «Non di solo pane vivrà l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4, 4). Il pane è il primo nutrimento, ma più che seguire tale frase si è abbandonato Gesù in quel deserto e ci si è proclamati Dio al suo posto. È in atto il tripudio dell’io cucino a casa.
I libri, la musica e i buoni film sono stati ignorati alla stessa velocità con cui dagli scaffali dei supermercati sono scomparsi farina e lievito. Non di solo pane vive l’uomo, infatti, ma di ogni leccornia che esce dal forno di casa propria.
Le relazioni sociali sono dunque divenute assai più attive che in passato. E tuttavia il pericolo che esse possano mutare profondamente, magari mantenendo le modalità attuali ritenute più comode e vantaggiose, è molto forte. La socialità a causa del virus è diventata virale, ma anche addomesticata.
L’umano, la cui socialità non si è dunque persa ma anzi acuita sotto altre forme, è anche costitutivamente politico. La città è il suo habitat naturale e ciò che alcune riprese consegnano ai nostri occhi è a dir poco perturbante. Gli umani hanno difatti lasciato vuote le strade, le piazze e i luoghi di aggregazione (qualsivoglia) per scivolare nei loro buchi domestici in cui sentirsi protetti e al sicuro. Oltre che essere una minaccia alla vita il virus è una minaccia politica.
Personalmente ritengo opportune le misure adottate dai governi di quasi tutti i Paesi del mondo con importanti focolai di contagio al loro interno, e però non posso lasciare inevase alcune considerazioni di ordine politico su come queste misure sono state accolte dalla popolazione. Più che vedere sovrani inebriati dal potere sui corpi viventi mi è parso di notare Stati in grandi difficoltà, litigarelli ai tavoli delle trattative e molto incerti sulle decisioni da prendere. Persino gli Stati Uniti e la Cina, i due imperi mondiali, stanno fronteggiando in maniera molto maldestra l’emergenza politico-sanitaria.
Mettendo da parte per un momento la giustezza o no dei decreti restrittivi, emanati uno di seguito all’altro con una cadenza che neanche il peggiore dei dittatori si sarebbe sognato, stiamo assistendo con tutta probabilità alla più grande privazione delle libertà dal Dopoguerra a oggi. Si è disposti a manifestare il proprio dissenso per l’aumento di qualche centesimo del prezzo di prodotti che neanche lontanamente sarebbero motivo di appagamento reale e, in meno di una settimana, si è piombati in una condizione generale in cui l’intero territorio nazionale si è trasformato in un agglomerato più o meno ordinato di prigioni.
Si dirà che è corretto e che è da accettare e condividere. Soluzioni alternative come la tanto vituperata immunità di gregge ventilata dal premier inglese Boris Johnson, ad esempio, hanno fatto ribrezzo persino ai suoi stessi concittadini, sicché anche i più disincantati e sprezzanti del pericolo hanno dovuto fare un passo indietro. Talché la domanda da porsi, in modo anche freddo, gelido e spietato, mi sembra questa: per il corpo sociale ne vale davvero la pena? La sofferenza relazionale che rischia di lasciare cimiteri sociali e macerie ben peggiori di una guerra di bombardamenti è giustificata? Abbiamo davvero accettato di restare in casa e privarci di vivere sotto i raggi del sole per «salvaguardare», usando le parole stavolta del nostro presidente Giuseppe Conte, «la salute dei [nostri] nonni»?
Il senso civico e la solidarietà, che potrei aver avuto io come tanti altri che hanno scelto con coscienza di aderire a quanto indicato nel rispetto dei valori democratici e costituzionali di difesa dei più fragili, sono stati i veri moventi dell’io resto a casa? O è stata la paura di infettarsi, di passare qualche brutta giornata a letto, o persino di morire, tradendo in questo modo la convinzione così scorretta e rovinosa del dover continuare a vivere a tutti i costi e qualunque cosa accada, anche di calamitoso?
Malgrado voglia credere alla prima possibilità, la seconda, come appassionato di Tucidide, Hobbes e Céline, mi convince di più. Perché più che di civiltà si tratta della paura del contatto uscendo da casa, della distanza da tenere costante, del calore umano da ripudiare. Necessario, si dirà, ma allo stesso tempo agghiacciante, di un gelo nell’anima da far morire proprio quel calore che invece ci tiene vivi, il calore del mondo esterno, del cielo azzurro e della primavera che nel frattempo si risveglia. La socialità nell’epoca della sua riproducibilità grazie ai telefoni, ai Social, alle videochiamate, alla cucina nullificante che sforna vani riempitivi di pancia e non della mente è una socialità all’insegna del freddo.
C’è il calore del desiderio, del volersi abbracciare, di uomini e donne separati che vogliono ardentemente ricongiungersi. Ma c’è anche, e direi soprattutto, il freddo del risentimento sociale, dell’odio verso gli untori irresponsabili, della malevolenza verso la cultura e il parlar bene indici di pensare e vivere bene. E ciò accade perché nell’epoca della riproducibilità su Facebook e in luoghi di tal genere si preferisce, com’è ovvio, riprodurre e non produrre, per la gloria e il tripudio di teorie cospirazioniste, foto di sé e della propria tavola, deliri non da contagio ma da mancanza di contatto etico e conoscitivo.
Per fortuna ci sono umani che producono oltre Facebook e ogni falsa riproducibilità, che hanno di vista ciò che è originale, autentico, unico. Umani che in casa hanno i forni ma usano le loro biblioteche, hanno le finestre ma non fanno flash mob e guardano il cielo sentendo il cosmo pulsare, hanno i computer ma leggono la buona rete. La socialità esasperata e resa virale dal Covid-19 e dalla pervasività con cui è aumentata nelle nostre case ha rappresentato molto più chiaramente dell’epoca avanti virus, nelle immagini sfocate e nei suoni confusi delle tante videochiamate di gruppo, ciò che rende la vita animata quello che è, l’anima della vita che è il calore.
In conclusione, il mio pensiero va come sempre a Marcel Proust, uno che gli umani li ha capiti fino in fondo, ben prima di ogni virus e riproducibilità tecnica e virale. Si direbbe una chiusa necessaria e originale come le pennellate di Leonardo, insostituibili. Per quanto orribili, odiosi e dannati siano gli altri umani per ciascuno di noi, sono infine necessari, e apprendiamo ciò ogni giorno di quarantena che passa, perché essi soli possiedono «la chaleur que nous ne pouvons pas trouver en nous-même»[1].
[1] M. Proust, Le côté de Guermantes, in À la recherche du temps perdu, a cura di T. Laget e B. Rogers, Gallimard, Parigi 2019, p. 1052; «quel calore che non possiamo ritrovare in noi stessi», trad. di M.T. Nessi Somaini, Rizzoli, Milano 2012, p. 443.