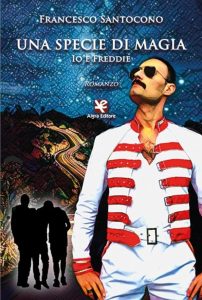Recensione a:
Maurizio Bettini
Con l’obbligo di Sanremo
Einaudi, Torino 2013
Pagine 136
€ 16,00
di Mattia Spanò
Evento istituzionalizzato, fatto sociale e momento di socialità, intervallo momentaneo di paralisi collettiva, occasione di guadagno e di aridità, il festival di Sanremo accompagna – con le sue contraddizioni – le vite degli italiani dal 1951. L’annuale e carsica organizzazione del programma televisivo – che, in quanto tale, a regole televisive soggiace – si addensa dirompentemente nell’arco temporale che va dal pre-Sanremo al post-Sanremo, transitando per gli astronomici picchi di share raggiunti durante le serate del Festival in quanto tale. Televisivamente, poco è lasciato al caso: l’imponente macchinario produttivo dell’industria culturale, con precise manovre, sorvola patine emotive, palati musicali, aspettative intergenerazionali, propensioni contenutistiche. Una cifra distintiva – più o meno marcata – riemerge, tra proposte di varia natura e levatura, ad ogni nuova edizione. D’altronde non è un caso che ‘sanremese’ sia diventato, nel tempo, un termine categorizzante: si definisce tale ogni brano che, idealtipicamente, rivanga una certa struttura, assimilabile a ciò che si ascolta, di anno in anno, al Festival della canzone più famoso d’Italia.
Stando a ciò, l’accadere di un simile evento, non può che restituire le tensioni, gli orientamenti, le bordature, gli orizzonti maggiormente frequentati dal corpo collettivo su un piano ben più ampio dell’universo musicale – che, in parte, da questo scaturisce; nonché le direzioni e gli assetti di riferimento prediletti dall’industria culturale, informazionale – televisiva e non solo.
Sanremo si impone, dunque, come un imperativo, un obbligo per chi ne plasma la struttura dalle retrovie del sistema televisivo – in maniera più o meno esposta – affinché il Festival della canzone italiana diventi tale (un obbligo, appunto) anche per i fruitori televisivi. E si fa così paradigma di quell’organizzazione spaziale, temporale e tematica della composita bolla di simboli, valori, norme e credenze, ad oggi con cura tessuta dall’industria culturale. Tanto più in un’epoca caratterizzata alle radici da un impianto comunicativo-relazionale massmediatico. Se il mezzo è, infatti, il messaggio – o le coordinate strutturali e contestuali intervengono almeno con una certa veemenza sui contenuti veicolati – l’approccio prospettico e l’elaborazione di ciò che si consuma, assume inevitabilmente una certa postura, curvatura, temporalità. E la quantità – in questo caso l’ipertrofico spettro di stimoli ai quali si è costantemente sottoposti – interviene strutturalmente sulla qualità della fruizione. Sia dal punto di vista dei comunicatori di professione, tesi ad accattivarsi la più ampia, variegata e potenzialmente ancora-più-estendibile cornice di consumatori. Sia dalla prospettiva di questi ultimi, in buona parte orientati da stringenti, ma non ineludibili, meccanismi di velocità, funzionalità, produttività. Allora, chi è l’attore principale di questo stato di cose? Il Deus ex machina, la mano invisibile che «dirige, valuta, indirizza la nostra cultura, pur non avendo alcuna posizione politica ufficiale»? (p. 4). Maurizio Bettini ipostatizza, nel suo ultimo romanzo Con l’obbligo di Sanremo, questa impalpabile ma presentissima e decisiva entità; la rende persona – carne, vene e idee – nella figura del «Soprastante», nonché «Responsabile Generale della Nostra Cultura» (p. 4).
Uomo dotato di una precisa individualità, certo. Di una storia, di passioni e di un ufficio nel quale lavora. Ma recante in sé gli ambigui e sfuggenti tratti dello status quo culturale, di cui è garante e sostenitore con il proprio operato. Nessuno ha contezza degli effettivi indirizzi culturali di colui che indirizza la cultura. Chi è convinto che il «Soprastante» sia praticamente onnisciente è affiancato da coloro i quali credono fermamente che parametri il proprio lavoro sulla base del mero giudizio popolare. Trapela poco di quanto il «Soprastante» discute nelle riunioni organizzate nel suo ufficio – tappezzato di riviste di Gossip, sullo sfondo di una costante proiezione di telequiz e con vista su Piazza Montecitorio. È impresa ardua incontrarlo, fissare un appuntamento in tempistiche decenti. Ma chi riesce a farlo è il protagonista del romanzo in questione, dipendente ed ex compagno di scuola del «Soprastante». Motivo dell’incontro? Richiedere una licenza, otto giorni di libertà dal martellante lavoro di programmazione ed organizzazione culturale. Otto giorni «fuori da tutto» (p. 8). Anche – come il «Soprastante» ha modo di chiedere al suo dipendente – dal più stringente «appuntamento fisso delle diciannove e quarantacinque» (p. 9). Otto giorni di libertà per dedicarsi ad un viaggio, zainetto in spalla e taccuino alla mano. Richiesta accordata dal «Soprastante» ma ad una precisa condizione: «E otto siano […] ma resta l’obbligo di Sanremo!» (p. 10). Ed ecco che il Festival più famoso della canzone italiana emerge nella sua ineludibile necessità, dal punto di vista dell’industria culturale: un obbligo, per chi ci lavora, affinché diventi quasi obbligante seguirlo per gli spettatori. Una licenza, seppur breve, è accordata a chi lavora per il «Responsabile Generale della Nostra Cultura». Nessuno sconto, però, su Sanremo, paradigma della bolla culturale-generalista, picco di condensazione di tendenze, indirizzi, orientamenti. Ed ecco che, concessa la licenza, il protagonista si avventura in un viaggio di ricerca dalle più disparate e polifoniche ambientazioni. Come si diceva, con zainetto in spalla e taccuino alla mano. Oggetti quotidiani, facilmente reperibili, se si vuole anche apparentemente banali ma non nella cornice tracciata da Maurizio Bettini. Per un dipendente del «Soprastante», zainetto e taccuino – riposti in «uno sgabuzzino che aveva l’aria di una scarpiera» (p. 12) – sono anch’essi una concessione. Perché occasioni di libertà, di indugio, di ragionata riflessione che mal si accordano con la frenetica temporalità dettata dall’apparato produttivo odierno: «Se annotando si osserva, rileggendo si pensa, soprattutto se si pensa in un modo che, almeno a quel che mi sembra, è diverso dal solito» (p. 40).
In un universo fondato sull’iterazione dell’Eguale – in vista del più smodato ed acritico consumo – pensare diversamente si configura come un potere che frena. Si struttura come un potenziale pericolo da arginare:
Dev’essere questo il motivo per cui il Soprastante è così restio a concedere l’uso dello zainetto con penna e taccuino. È come se la possibilità di tornare ad libitum su quello che si è scritto permettesse alla mente di emergere, almeno per un po’, dalla bruma in cui normalmente si aggira, o forse sarebbe meglio dire si perde. Una bruma leggera, ma fitta, composta di parole televisive, di urla o cinguettii pubblicitari, di titoli a effetto, di slogan, di espressioni alla moda, di luoghi comuni […] che flottando attorno e dentro di noi formano una sorta di logosfera (pp. 40-41).
Da un lato l’industria culturale, capitanata dal «Responsabile Generale della Nostra Cultura»; dall’altro il corpo collettivo, gettato in una fitta coltre di spunti dal retrogusto opprimente, paralizzante, autoreferenziale, autotelico. Che di corrività si nutre, che su un tappeto di sterile – sia sul piano teoretico, sia a livello prassico – novità per la novità si articola. I movimenti sono limitati; i migliori approdi si rivelano, spesso, vicoli senza sbocco scevri di prospettive altre, poveri di occasioni di sperimentazione dell’oltre rispetto al già-dato. In questa cornice si fa scempio della complessità dell’intero che, da frammenti, abitiamo. In questa «vera e propria bolla di lógos, di pensiero e di parole, non si sa se imposta dal Soprastante o spontaneamente condivisa: all’interno della quale, comunque, tutti noi respiriamo, o meglio boccheggiamo, tanto che non riusciamo più neppure a percepirla. Fino al momento in cui, però, si ha la possibilità di rileggersi» (p. 41). E quindi ri-pensarsi, ri-collocarsi, ri-configurarsi, ricostituire ininterrottamente ed asintoticamente la complessità del mondo. Ed ancora rigenerarsi e rigenerare. Tentare di accostarsi, approssimarsi, abitare lo straordinario dell’ordinario. In un continuo, chiaroscurale, lavoro di ricerca, di cui il protagonista dell’opera si fa emblema: «Ora che la logosfera, fuori e dentro me, si andava schiarendo sempre più, il flusso dei pensieri mi portava lontano – o per meglio dire molto vicino, la più sconvolgente forma di lontananza che possa esistere» (p. 47). Da questi presupposti si articola il viaggio interiore ed esteriore, di ricerca del sé e del mondo, teoretico e prassico del protagonista di Con l’obbligo di Sanremo. In un flusso esistentivo ed esistenziale, architettonico e spirituale, spaziale e temporale, dalla forma – anche sul piano linguistico-espressivo oltre che al livello dell’avvicendarsi degli eventi – del tornante. Tra una sosta sui concetti di identità ed autochtonía – nel vivo di una disputa mirata ad un presunto primato culturale – e momenti di «una giornata come quella, non si sa se più umida o più gelida», in cui «era indispensabile mettersi sotto la protezione di Dioniso» (p. 55). Poi piccole facoltà clandestine, cenacoli culturali auto-organizzati in assenza di alternative, dove docenti non-docenti tengono corsi a contratti gratuiti. Un controsenso tanto assurdo quanto reale. Uno spaccato di ciò che significa, ad oggi, in Italia, tentare di fare ricerca. Dove – in non pochi casi – impegno, volontà e passione di molti studiosi soverchiano a tal punto l’interesse economico-materiale, da farsi catalizzatori di occasioni di incontro, reciproco arricchimento, proteiforme approfondimento. Anche dove non sono strutturalmente garantite soluzioni sistemiche. La forza dell’esserci che si impone su squallidi meccanismi che di cultura si ammantano e poi, nei fatti, la offendono. Emozionante.
Ed ancora: itineranti talk show animati dal più banale chiasso, improbabili questioni astrologiche, treni graffitati, piazze gremite, strade deserte, antiche biblioteche rasentanti l’oblio cittadino ma ancora depositarie della più viva delle voci. Un viaggio di studio – di quelli che ci si è quasi dimenticati – sullo sfondo di uno spettro obbligante, irretente. Con l’obbligo di Sanremo, decretato con «geometrica precisione» da un «Soprastante» che sembra quasi aver «ereditato i poteri posseduti un tempo dall’anánke» (p. 119). Ma la cui avanzata, come è dato ad ogni uomo – frammento sottoposto all’anánke – appartiene pur sempre anche all’orizzonte della téchne. Sta poi ad ogni singolo individuo – gettato nel mondo e con-il-mondo – definire asintoticamente il proprio verso-dove.
Accogliere ed elaborare la complessità dell’evento-vita è una difficile pratica di verità dalle decisive implicazioni etiche e relazionali. Non sempre ripaga abitarla in un contesto che cerca di smussarla, contrastarla, estrometterla. Ma, probabilmente, restituisce già qualcosa ripercorrere il risonante sfogo di Cyrano che accompagna, nelle battute finali, il protagonista dell’opera: «Dite forse che è inutile? Ma per me fa lo stesso, / non ci si batte solo sperando nel successo. / Quando la lama è vana fa ancora più faville!» (p. 127).