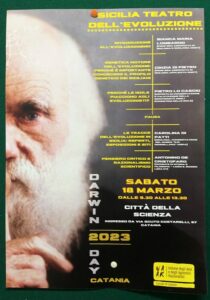di Sarah Dierna
Prima di dire qualcosa sul romanzo di Cormac McCarthy, La strada appunto, vorrei partire da uno dei dialoghi di Pavese che porta lo stesso nome.
In esso Edipo, ormai cieco, incontra un mendicante col quale si tormenta per il suo destino già deciso fino all’ultima fibra del corpo, per la condanna di sapere che qualsiasi gesto, anche il più trascurabile, sia stato già scritto ed è dunque destino che si compie. Una delle ultime battute che il mendicante rivolge al re di Tebe è significativa per la sua esattezza: «Non siamo noi che abbiamo fatto il nostro sangue»[1].
A seconda di come si scelga di interpretarla, questa frase può significare tante cose. Tra tali interpretazioni, c’è sicuramente la risposta data a Edipo nell’affermare un totale determinismo sulla vita e sugli eventi che interessano le faccende umane. Può anche volere dire che questo destino già stabilito sia il sigillo di ogni nuova creatura che non ha scelto di esistere ma che, esistendo, inevitabilmente subisce tutte le conseguenze della sorte che è propria della condizione umana. Appartiene agli esseri umani il dolore di sapere il proprio morire e di vedere quello dei propri genitori precederci; appartiene agli esseri umani il dolore per gli affetti perduti, per l’abbandono delle persone alle quali vogliamo bene e per il vuoto che la loro scomparsa ha lasciato.
C’è un destino già scritto anche per i protagonisti di McCarthy, un padre e un figlio che non hanno nome, costretti a lasciare il proprio focolare domestico e a mettersi in viaggio verso Sud alla ricerca di una terra promessa che possa essere ancora calda, fertile, accogliente e non «sterile, erosa, sventrata»[2] come quella che calpestano e dalla quale scappano.
Non c’è più un luogo che non sia stato arso dalle fiamme e ridotto in cenere; anche gli alberi sono crollati e i pochi semi rimasti sul suolo sono già marci per favorire una nuova fioritura; non si trovano più case che siano ancora lo spazio confortevole di una famiglia.
Il viaggio, questo grande archetipo della letteratura che coinvolge anche i due personaggi de La strada, non è che una metafora della vita stessa nelle sue asperità, nel suo ostinato percorso che conduce al domani e, giorno dopo giorno, alla morte.
McCarthy riesce a rendere l’avvicendarsi di questo destino restituendolo mediante uno stile generosamente descrittivo ma monotono e ripetitivo che rende i luoghi quasi identici tra di loro, gli itinerari tutti uguali e così i momenti di sosta; uno stile che accompagna il lettore dalle prime fino alle ultime pagine senza nessun particolare sconvolgimento o sorpresa. Non c’è infatti da aspettarsi niente perché, benché possano cambiare le circostanze particolari, gli eventi sono sempre inseriti nella stessa cornice già inchiodata al muro in cui la vita si dispiega e dove «exister», per utilizzare una metafora assai efficace di Théophile de Giraud, «n’est ainsi rien d’autre qu’errer dans une forêt de craintes où la question n’est jamais de savoir si le Mal nous atteindra, mais seulement quand et sous quelle forme il fera de nous sa proie terrifiée»[3].
1. Il rapporto con il divino
Il cuore pulsante del romanzo, più che sull’anelata meta da raggiungere o sul fumo di una terra che sospira finalmente di sollievo per la scomparsa – o comunque significativa riduzione – di Homo Sapiens, batte intorno alla relazione padre-figlio: alla cura attenta e totale del primo per rendere lieve il cammino del secondo; all’ingenuità e la tenerezza del secondo, schierato dalla parte dei buoni e ancora fiducioso che ‘lì sopra’ ci sia un Dio capace di vedere il loro segnale luminoso e dunque disposto a salvarli.
La fede mi sembra un tema spiccatamente presente nelle pagine di McCarthy. Invocata dagli esseri umani a garanzia di una vita immortale e come promessa di un aldilà felice, l’autore descrive i pochi reduci di questa esistenza naufragata come «gusci di uomini senza fede che avanzavano barcollanti sul selciato come nomadi in una terra febbricitante» e lo schizzo divino che li sosteneva e li indirizzava «la rivelazione finale della fragilità di ogni cosa». Tutte queste «vecchie e spinose questioni si erano risolte in tenebre e nulla» (p. 22).
Mentre il ragazzino sembra conservare intatta la fiducia nel suo dio, il viaggio rende sempre più barcollante il cammino di fede del padre che fa del figlio soltanto l’unica prova dell’esistenza di un essere massimamente buono.
Nel romanzo, il ‘deicidio’ viene compiuto però da uno dei pochi umani che i due incontrano lungo la strada. Un anziano che il viaggio, la maturità e la saggezza degli anni, hanno aiutato a rendersi conto che «non c’è nessun Dio e noi siamo i suoi profeti» (p. 129). Siamo coloro ai quali spetta annunciarne la morte riconciliandosi col nulla.
Un personaggio, questa improvvisa presenza, che sembra avere quasi le sembianze di Tiresia: cieco, che riferisce di avere vissuto come un animale e disposto a riporre fiducia ormai soltanto nel suo bastone. Un indovino che ha da sempre considerato assurda la sicurezza della gente verso il domani; un ultimo messia – come quello raccontato dal filosofo norvegese Peter Wessel Zapffe[4] – che ha compreso che gli dèi esistono laddove esiste un essere umano che ha bisogno di immaginarsi delle entità superiori capaci di dare un senso, un ordine e uno scopo al cosmo che in se stesso è privo di senso, di ordine e di scopo, e che per questo alla fine dei giorni ha compreso che «le cose andranno meglio quando non ci sarà più nessuno» (p. 131).
La totale dipartita degli umani e di ogni altra specie senziente è ciò in cui soltanto si può sperare affinché nella terra non ci sia più nessuna angoscia. Con queste parole si congeda il messia Zapffe:
The life on many worlds is like a rushing river, but the life on this world is like a stagnant puddle and a backwater. The mark of annihilation is written on thy brow. How long will ye mill about on the edge? But there is one victory and one crown, and one salvation and one answer: Know thy selves; be unfruitful and let there be peace on Earth after thy passing[5].
E tuttavia alla salvezza dell’assenza Homo sapiens contrappone invece la salvezza generativa della presenza.
2. Genitori e figli
Alla durezza di tale verità fa da contraltare la dolcezza di un bambino che gioisce della luce affinché il padre possa leggergli delle storie allegre a cui potere, nonostante tutto, credere; ingenuamente convinto che nel mondo non tutti sono ‘cattivi’ ma esistono anche i ‘buoni’; che conserva ancora una scintilla della speranza. Così domanda al padre:
Ce la caveremo, vero, papà?
Sì. Ce la caveremo.
E non ci succederà niente di male.
Esatto.
Perché noi portiamo il fuoco.
Sì. Perché noi portiamo il fuoco (p. 64).
Un Prometeo bambino troppo amico degli umani per temerli; che porta il fuoco dentro di sé; capace di obliare la morte nel mostrarsi fedele al futuro dei giorni e di rendere immortale il padre continuando con lui un dialogo che lo renderà per sempre vivo anche dopo la sua scomparsa.
Anche per non morire i genitori decidono di generare e di spartire con nuove creature metà del proprio codice genetico. Il padre ha infatti scorto nel figlio la prova del ‘verbo’ di Dio, il compagno con cui condividere lo spazio e il tempo, ma soprattutto la promessa di potere esistere nella memoria del bambino e nella strada che questi avrà ancora da solcare.
Dal punto di vista biologico è giusto che siano i genitori a precedere la morte dei figli o, in alternativa, che siano i figli a piangere per la morte dei genitori e non il contrario. Ma nel fondo di questa legge taciuta e condivisa forse c’è anche l’incapacità da parte dei genitori di tollerare il dolore atroce della perdita dei figli dai quali ci si aspetta altre pene e altre preoccupazioni, ma mai questa. I figli devono invece soffrire la scomparsa dei propri genitori. Michela Marzano nel primo dei suoi romanzi, L’amore che mi resta, ha giustamente notato che noi abbiamo un modo per nominare la perdita dei genitori da parte dei figli, orfano appunto, ma non esiste un termine che sia in grado di etichettare la scomparsa prematura dei figli da parte dei genitori. Un evento senza nome che non trova spazio tra le fantasie che un padre o una madre immaginano per il loro bambino.
E infatti il padre pensa di dare la morte al figlio per assolverlo da tanto dolore, «ce la farai? Quando sarà il momento? Quando sarà il momento non ci sarà tempo. È questo il momento. Bestemmia Dio e muori. E se si inceppa? Non può incepparsi. Ma se si inceppa? Saresti capace di fracassare quel cranio adorato con un sasso?» (pp. 87-88), ma non ci riesce e non lo può sopportare: «Non ce la faccio. Non ce la faccio a tenere fra le braccia mio figlio morto. Credevo che ne sarei stato capace, e invece no» (p. 212).
In questo modo un padre che ha fatto di tutto per evitare ulteriore sofferenza al figlio e non fargli mancare niente, alla fine non gli farà mancare nemmeno il dolore.
Il bambino, dal canto suo, impara presto a non credere più alle bugie dell’uomo e si ritrova a fare i conti con la morte, ad averne paura e a scoprirne l’inevitabilità.
Il dispositivo consapevole assottiglia la distanza del figlio dal padre che prima non era in grado di comprendere perché condivideva i suoi ricordi felici con un essere umano di una generazione diversa che non ha avuto la possibilità di conoscere quei mondi e di evocarli quindi con rimpianto. Tale inconsapevolezza del mondo perduto salva in qualche modo il ragazzino che infatti geme per ogni nuova esperienza che si pone alla sua vista dal momento che «entrano in testa poi ci restano per sempre» (p. 10).
È significativo che i sogni e le fantasie del bambino mutino piano piano la loro trama per adagiarsi in modo sempre più veritiero sulla realtà, rinunciando pertanto alla fantasia.
«E vissero infelici e scontenti» o, se si preferisce, «e morirono felici e contenti» sembra infatti la conclusione più adatta, quella tristemente più vera.
3. Non esserci stati o non esserci più
Una presenza quasi aleatoria, evocata soltanto nel ricordo del padre, è la figura della madre: un personaggio che abbandona la vita – così pare ma non è detto in modo esplicito – con grande forza e determinazione.
Di questa donna colpisce soprattutto l’apparente efferatezza con cui descrive la nascita del figlio quando il suo cuore non si è affatto riempito di gioia ma si è spezzato perché profondamente consapevole del venire in un mondo fatto di ombre e non di luce. È un atto d’amore la scelta di non utilizzare uno dei proiettili rimasti nel compiere l’indicibile gesto visto che sono soltanto due adesso e, qualora se ne fosse servita di uno, qualcun altro – il padre o il figlio – sarebbe rimasto condannato a vivere o a patire la morte anziché raggiungerla nel modo meno doloroso e più rapido possibile.
Il bambino non parla mai della mamma ‘andata via’ se non in una circostanza in cui esprime al padre il desiderio di volere essere con lei in quel momento. E mentre come marito non è stato in grado di dire niente alla moglie che sperava di «raggiungere il nulla eterno» perché in quel momento «non [aveva] argomenti perché non ce ne sono» (p. 45), replica al bambino di smetterla di dire queste cose. Si tratta di un meccanismo di isolamento ben descritto nel racconto del filosofo norvegese:
By isolation I mean a completely arbitrary rejection of disturbing and destructive thoughts or feelings. […] In our daily social life, isolation manifests itself through universal, unwritten agreements to conceal our existential condition from one another. This concealment begins with children, in order to save them from being rendered senseless by the life they have just begun, to preserve their illusions until they are strong enough to lose them. In return, children are forbidden to embarrass their parents by untimely allusions to sex, shit, and death. Among adults there are rules about “proper” behavior, and we see them quite plainly when a man who cries in the streets is taken away by the police[6].
Il padre non si mostra mai nella sua fragilità, non consegna mai al bambino le sue paure nemmeno alla fine; si sforza di tenere lontano da lui il pensiero della morte che pure brulica in quelle terre sterili chiedendo in cambio che il bambino non si accosti a essa con anelito e desiderio. In tal caso sarebbe anche la propria fine, sarebbe ritrovarsi davanti al tarlo della propria morte che aveva cercato di non evocare più.
Il figlio tanto amato rappresenta per il genitore un ancoraggio, una necessità costruita che diventi la ragione della propria esistenza, un sostegno esso stesso; qualcosa che la moglie aveva ben compreso: «L’unica cosa che posso dirti e che non sopravviverai per te stesso. Lo so perché io non sarei mai arrivata fino a qui. Le persone che non hanno nessuno farebbero bene a imbastirsi qualche fantasma decente. Dargli il soffio della vita e convincerlo a proseguire con parole d’amore» (p. 45). Rimossa la ragione per restare rimarrebbe soltanto la ragione per andare via per sempre.
A ciascuno spaventa la propria morte. Anche quando l’alternativa sarebbe un’esistenza precaria e fredda, la morte fa sempre un poco paura. Lo confessa lo stesso anziano di prima: «Forse vorrei essere già morto. Quando uno è vivo la morte ce l’ha sempre di fronte, oppure potrebbe desiderare di non essere mai nato». In questo modo, se non nati, la morte non ci sfiorerebbe, e con essa nemmeno il desiderio, a tratti quasi inspiegabile, di permanere.
Ahimè è vera la risposta dell’uomo quando il cieco continua domandando «crede che sarebbe chiedere troppo» e il primo conclude: «Quello che è fatto è fatto» (pp. 128-129). È il «sangue» di Edipo che nessuno è in grado di scegliere per se stesso e di cui il corpo si ritrova un recipiente.
E tuttavia, «parlando», fa dire Pavese alla fine dello stesso dialogo, «qualcosa si placa nel cuore»[7]. Il dialogo del padre con il figlio e del figlio con il padre è un elemento fondamentale in questo romanzo di McCarthy. Avviato lungo la strada e senza alcun segno di punteggiatura, quasi a indicare che si sta svolgendo mentre il viaggio continua, lo scambio tra i due, benché ridotto al minimo e a tratti monosillabico, esprime l’unica scheggia di tenerezza e di dolcezza che i due riescono a ritagliarsi nel loro tragitto esistenziale. L’unica scheggia di tenerezza e di dolcezza che talvolta aiuta gli umani ad alleviare il peso dei giorni e a rendere il viaggio a tratti persino piacevole.
[Foto di G. Cobianchi, tratta da VETEM. Nel nido delle aquile, Selfself, Milano 2022]
[1] C. Pavese, La strada, in Id., Dialoghi con Leucò, a cura di A. Sichera e A. Di Silvestro, Mondadori, Milano 2021, p. 66.
[2] C. McCarthy, La strada, (The Road, 2006), trad. di M. Testa, Einaudi, Torino 2007, p. 135. I numeri di pagina delle successive citazioni da questo libro saranno indicati direttamente nel testo.
[3] T. de Giraud, L’art de guillotiner les procréateurs. Manifeste anti-nataliste, La Mort-Qui-Trompe, Nancy 2006, p. 23.
[4] P.W. Zapffe, The last Messiah (Den sidste Messias, 1933), in Aa. Vv., Wisdom in the Open Air: The Norwegian Roots of Deep Ecology, edited by P. Reed and D. Rothenberg, translated by S. Kvaløy with P. Reed, University of Minnesota Press, Minnesota 1992.
[5] Ivi, p. 52. Il corsivo è mio.
[6] Ivi, p. 44.
[7] C. Pavese, La strada, in Id., Dialoghi con Leucò,cit., p. 66.